Anna
Achmatova, Amedeo Modigliani ed altri scritti, a cura
di Eridano Bazzarelli, Milano, SE, 2004
Questo
volume comprende alcuni degli scritti in prosa di Anna Achmatova
(1889-1966): scritti critici e di memoria. Ritroviamo qui
le stesse caratteristiche dello stile dell’Achmatova poetessa: limpidezza della
lingua, ricchezza della sostanza letteraria ed esistenziale,
intensa partecipazione emotiva filtrata attraverso il rigore
della parola. Le prose critiche costituiscono capitoli diversi,
interiormente legati, di un libro ideale, mai compiuto, dedicato
a Puškin, che fu veramente il grande maestro e il grande
ispiratore di Anna Achmatova. Di carattere memorialistico (ma
anche, in parte, critico) sono gli altri scritti, dedicati
a poeti come Blok e Mandel’štam, a poeti e traduttori
insigni come Lozinskij: tutti momenti fondamentali della cultura
russa, con una eccezione: Amedeo Modigliani. Forse non si tratta
di una vera e propria eccezione: anche Modigliani, se non altro
per il tenero e delicatissimo affetto che lo legò per
qualche tempo ad Anna e per il bellissimo ritratto che dipinse
di lei, ci pare abbia il diritto di far parte di una storia
ideale della cultura russa. In quel famoso ritratto, più che
Anna Achmatova si rispecchia il «mistero» di Anna
Achmatova: la straordinaria purezza della sua forma e la profonda
inquietudine della materia del suo poetare, l’aspirazione
a un’emozione rinascimentale e il presagio del tumulto
e delle angosce. E le rose che Anna gettò un giorno
lontano nel cortile parigino di Modigliani mandano sempre il
loro delicato profumo, anche attraverso le altre pagine del
libro. Nei suoi ricordi, con pochi tratti essenziali, brevi
illuminazioni, rievoca dunque gli amici poeti, risuscitando
immagini e sentimenti del passato e permettendo anche di capire
aspetti meno noti della personalità di quegli artisti
straordinari, a cui Anna era legata da profonda amicizia.
(dalla seconda di copertina)

Nota biografica
1889 – 1906
Anna
Andreevna Gorenko, universalmente conosciuta con lo pseudonimo
di Anna Achmatova, nasce, terza di cinque figli, l’11 giugno 1889 a Bol’šoi
Fontan, un sobborgo di Odessa, da Andrej, ingegnere della flotta
navale, e da Inna Erazmovna, di nobile famiglia, che aveva
preso parte al movimento rivoluzionario nel gruppo populista «Narodnaja
Volja» (La volontà del popolo).
L’anno successivo il padre va in pensione, e la famiglia
si trasferisce nei dintorni di Pietroburgo: prima a Pavlovsk
e poi, sino al 1905, a Carskoe Selo, residenza estiva della
corte imperiale e sede di un liceo che ebbe tra i suoi allievi
anche A. S. Puškin. In uno dei numerosi frammenti autobiografici,
scrive: «Ho imparato a leggere sui Libri di lettura di
Tolstoj e a cinque anni, ascoltando la mia insegnante, ho incominciato
a parlare francese. Ho scritto la mia prima poesia quando avevo
undici anni».
A dieci anni supera una grave malattia, probabilmente una forma
di vaiolo. Frequenta il ginnasio di Carskoe Selo, dove conosce
il già noto poeta Nikolaj Stepanovič Gumilëv,
che si innamora perdutamente di lei, sino a tentare il suicidio.
Nel 1905 i genitori si separano e Anna si trasferisce, con
la madre e i fratelli, a Evpatorija, sul Mar Nero. Termina
gli studi ginnasiali a Kiev e si iscrive alla facoltà di
Giurisprudenza presso i Corsi femminili superiori, essendo
a quel tempo l’accesso all’università vietato
alle donne.
1907-1913
Nel 1907
pubblica su «Sirius»,
la rivista edita da N.S. Gumilëv a Parigi, dove egli si è trasferito
l’anno precedente, una poesia a firma A.G.
Nel 1910 acconsente a sposare Gumilëv, che non ha mai
smesso di amarla. Dopo aver trascorso insieme alcune settimane
a Parigi, dove Anna conosce, tra gli altri, Amedeo Modigliani,
torna in Russia, a Pietroburgo. Lascia la facoltà di
Giurisprudenza e frequenta i corsi teorico-letterari, conoscendo
il poeta Innokentij Annenskij, che considererà uno dei
suoi maestri.
Nel 1911 Gumilëv, con S. M. Gorodeckij, fonda la Ghilda
dei Poeti {Čech Poetov), da cui nascerà il movimento
acmeista, sorto come reazione all’imperante simbolismo,
che ha in Aleksandr Blok il suo più alto rappresentante.
In un frammento autobiografico Anna scrive: «Nel 1910
fu proclamata la crisi del simbolismo, e i giovani poeti non
seguivano più questa tendenza. Gli uni scelsero il futurismo,
gli altri l’acmeismo. Io divenni acmeista». Faranno
parte del movimento anche Osip Mandel'štam e Michail
Kuzmin.
Nella primavera di questo anno Anna Gorenko torna a Parigi
e la sua amicizia con Modigliani si approfondisce. Insieme
leggono i poeti francesi, soprattutto Baudelaire, insieme vagano
per le strade di Parigi e visitano il Louvre, e Modigliani
le dedica una serie di ritratti, di cui solo uno è giunto
sino a noi.
Tornata a Pietroburgo insieme al marito, l’Achmatova
partecipa ai mercoledi letterari in casa di Vjačeslav
Ivanovič Ivanov, filosofo, filologo e poeta, il «pontefice
massimo» del simbolismo russo. In quell’attico,
la famosa Torre, i poeti recitano i loro versi, e lì si
impone all’attenzione generale l’Achmatova. Due
sue poesie vengono pubblicate su riviste pietroburghesi, e
inoltre inizia la sua collaborazione ad «Apollon»,
rivista considerata l’organo non ufficiale degli acmeisti.
Nel 1912 pubblica il suo primo volume di versi, Večer
(La sera), sostituendo il cognome paterno con quello della
nonna, Achmatova, principessa tatara. «Fu stampato in
trecento esemplari in tutto» scrive Anna. «La critica
lo accolse favorevolmente». Agli inizi di questo anno,
incinta, compie con il marito un viaggio in Italia (Genova,
Padova, Venezia, Bologna, Pisa, Firenze): «L’impressione
ricevuta dalla pittura e dall’architettura italiana fu
enorme:» scrive «simile a un sogno che ricordi
tutta la vita». Il suo unico figlio, Lev Nikolaevič,
nasce il 1° ottobre 1912.
Nel 1913 esce sulla rivista «Apollon», lo scritto
di Gumilëv Nasledie simvolizma i akmeizm (L’eredità del
simbolismo e l’acmeismo), una sorta di manifesto del
movimento.
1914 – 1920
Nel 1914
1’Achmatova
pubblica il suo secondo libro, Četki (Rosario). Allo scoppio
della guerra, dietro richiesta della stessa Achmatova e di
Mandel’štam, viene chiusa la Ghilda dei Poeti.
Nel 1915 si ammala di tubercolosi ed entra in crisi il rapporto
con Gumilëv, che viene inviato al fronte.
Dopo lo scoppio della Rivoluzione, esce, nel 1917, la sua terza
raccolta di poesie, Belaja staja (Stormo bianco).
La sua fama è all’apice.
Nel 1918 viene ratificato il divorzio con Gumilëv, e il
figlio Lev viene allevato dalla nonna paterna a Slepnevo. Si
conclude così un’unione che era stata decisiva
nella formazione poetica della Achmatova, e, ancora molti anni
dopo la sua tragica fine, Gumilëv continuerà a
essere presente nella vita e nei versi della poetessa. In questo
stesso anno si unisce a Mosca in seconde nozze con V. K. Šilejko,
famoso assiriologo e poeta appartenuto alla Ghilda. Un gran
numero di aristocratici, di borghesi, di intellettuali lasciano
la Russia.
Dei poeti appartenuti alla Ghilda solo Mandel’štam,
Zenkevič e l’Achmatova si rifiutano di lasciare
la patria. Si impiega come bibliotecaria presso l’Istituto
di Agronomia, e questo le permette di sopravvivere in quegli
anni terribili.
1921-1933
Nel 1921
Gumilëv viene
fucilato, con l’accusa di attività controrivoluzionaria.
Il 7 agosto muore Aleksandr Blok. La poetessa pubblica Podorožnik (Piantaggine),
e l’anno successivo Anno Domini MCMXXI, che
include anche le liriche della pubblicazione precedente e in
cui compaiono spunti di poesia civile e religiosa. Anche per
questo viene attaccata dalla critica ufficiale e i suoi libri
vengono proibiti e non si ristampano.
Nel 1925 si separa da Šilejko e si lega, sino al 1938,
al critico e studioso di arte Nikolaj Punin, ma anche questa
sarà un’unione tormentata: tra l’altro sono
costretti a vivere, a causa della crisi degli alloggi, nello
stesso appartamento con la ex moglie e la figlia di Punin e
Lev, tornato a vivere dal 1928 con la madre. Forse anche a
causa di questa situazione, e più in generale del clima
che la Russia sta vivendo e che già lascia presagire
il terrore staliniano che di lì a poco si sarebbe scatenato,
la produzione poetica dell’Achmatova è scarsissima.
Il 14 aprile 1930 Vladimir Majakovskij si suicida, e anche
questo appare come un presagio. In questi anni l’Achmatova
si dedica alla critica e alla traduzione; inizia i suoi studi
sull’architettura della vecchia Pietroburgo e su Puškin.
Rinnova inoltre l’antico sodalizio con Mandel’štam,
anche sulla base del comune amore per Dante e per la Divina
Commedia, che entrambi imparano a memoria in italiano.
1934 - 1940
Nel 1934
il Primo congresso dell’Unione degli scrittori sovietici dichiara il realismo
socialista come l’unica dottrina estetica del regime,
preparando così la repressione di tutto ciò che
era ad esso estraneo. Nel dicembre dello stesso anno l’assassinio
di Kirov offre a Stalin il pretesto di una prima ondata di
arresti di elementi giudicati sospetti, a cui seguiranno le
repressioni di massa. In campo artistico cadono vittime del
terrore, o vengono imprigionati, tra gli altri, Mandel’štam,
Babel’, Kljuev, Oleša, Mejerchol’d. E proprio
alla vigilia di questa carneficina l’Achmatova riprende
con intensità a scrivere versi, tra cui Voronez,
dedicata a Mandel’štam, che riflettono la situazione
tragica di quegli anni. Nel 1935 inizia a comporre Rekviem (Requiem),
ciclo di poesie ultimato nel 1940, e che per anni sarà conservato
a mente dalla stessa Achmatova e da alcune amiche, tra cui
Nadežna Mandel’štam, nell’impossibilità di
pubblicarlo e nel timore che, se trascritto, potesse venir
scoperto da elementi del regime e quindi distrutto.
Nel 1938 viene arrestato per la seconda volta Lev Gumilëv,
sospettato di ostilità al regime (era già stato
imprigionato nel 1935 e rilasciato per mancanza di prove).
Per diciassette mesi, in attesa della sentenza, l’Achmatova
si reca quasi tutte le mattine al carcere Kresty (Croci) di
Leningrado. Presso le sue mura, confusa tra le altre donne
in interminabili file, consuma il calvario dell’attesa
per poter consegnare un pacco, o almeno per avere notizie.
Lev viene condannato a morte, pena poi commutata nella deportazione.
Nel maggio dello stesso anno viene nuovamente arrestato Mandel’štam
e deportato in un lager presso Vladivostok, dove muore.
Agli inizi del 1940 appaiono sulle riviste «Zvezda» (La
stella) e «Leningrad» alcuni versi dell’Achmatova.
A maggio viene pubblicata una sua raccolta di versi scelti,
con il titolo Iz šesti knig (Da sei libri).
In ottobre ha il primo attacco di cuore.
Terminato Rekviem, inizia a comporre Poema bez
geroja (Poema senza eroe): lavorerà a quest’opera,
una delle sue più alte, per ventidue anni.
1941 – 1943
Il 22
giugno l’Unione
Sovietica è invasa dai nazisti. Lev Gumilëv, ancora
in carcere, si offre volontario ed è inviato al fronte.
Durante l’assedio di Leningrado l’Achmatova viene
evacuata e raggiunge Mosca; poi si trasferirà a Taškent,
nell’Uzbekistan. A Mosca incontra Marina Cvetaeva, tornata
in patria nel 1939 dopo un lungo esilio, che il 31 agosto si
suicida a Elabuga.
Nel 1943 esce a Taškent la raccolta poetica Izbrannoe (Poesie
scelte).
Nel maggio 1944 torna a Mosca. Dopo la fine della guerra, nell’atmosfera
euforica della vittoria, si stabilisce un clima di relativa
tolleranza, e liriche dell’Achmatova appaiono sulle riviste «Zvezda» e «Leningrad».
Viene anche invitata a prender parte a una serata di poesia,
riportando un enorme successo. Nell’autunno del 1945
ha un fugace rapporto amoroso con Isaiah Berlin, primo segretario
dell’ambasciata inglese, che rivedrà nel gennaio
dell’anno seguente: il rapporto diviene noto e scatena
le ire della polizia politica. Di ritorno a Leningrado riesce
finalmente a sapere, dopo lunghi anni di assenza di notizie,
che il figlio è vivo.
1946 -1952
Nel 1946 esce a Mosca un nuovo libro di poesie: Stichotvorenija 1909-1945
(Versi 1909-1945). Nello stesso anno viene espulsa dall’Unione
degli scrittori, con l’accusa di estetismo e disimpegno
politico. Viene sottoposta a un vero e proprio processo, e
sono accusati, con lei, anche il prosatore Michail Zoščenko
e le riviste «Zvezda» e «Leningrad»,
per aver pubblicato suoi versi, «estranei allo spirito
del popolo sovietico».
Il 30 settembre e il 6 novembre 1949 vengono nuovamente arrestati
Punin, che morirà in un lager, e Lev Gumilëv.
Nel 1950 l’Achmatova, che teme di perdere definitivamente
il figlio, accetta, su consiglio di amici, di scrivere un ciclo
di quindici poesie dedicate a Stalin e alla sua politica, Slava
miru (Gloria alla pace), che la rivista «Ogonëk» pubblica
ne1 195O. Con questo atto salva, verosimilmente, la vita al
figlio.
1953 - 1966
Nel 1953
muore Stalin, e negli anni successivi sue poesie ricominciano
ad apparire su riviste. Nel 1955 viene «riabilitata», nel clima di disgelo
dopo l’ascesa al potere di Kruščëv e
il XX congresso del PCUS. L‘anno successivo Lev Gumilëv
viene liberato.
Nel 1958 escono, a cura di A. Surkov, due antologie di versi
achmatoviani, ma nella Grande storia della letteratura
Russo-Sovietica, edita in questi anni dall’Accademia
delle Scienze dell’Urss, il suo nome non appare.
Nel 1962 trascrive su carta il testo di Requiem e
lo invia alla rivista «Novyj Mir», che non lo pubblica.
Uscirà l’anno successivo a Monaco di Baviera,
a cura dell’Associazione degli scrittori fuoriusciti,
e nell’Unione Sovietica soltanto nel 1987, sulle riviste « Oktjabr’»,
n. 3, e « Neva », n. 6.
Nel gennaio 1964 la traduzione di quel ciclo di poesie, a cura
di Carlo Riccio, viene pubblicata sulla rivista «Tempo
Presente» (anno XI, n. 1). In dicembre, su interessamento
della Comunità europea degli scrittori, Anna Achmatova
riceve di persona (è il primo permesso di recarsi all’estero
che le viene concesso dopo la Rivoluzione) il premio Etna-Taormina
assegnatole. Come segno di riconoscenza per il nostro paese
tradurrà, con N. Najman, i Canti di Leopardi.
Nel giugno 1965, in Inghilterra, riceve la laurea «honoris
causa» dell’università di Oxford. In autunno,
esce a Leningrado una sua raccolta di versi con il titolo Beg
vremeni (La corsa del tempo), che contiene, oltre a una
scelta vastissima dai primi cinque libri, le liriche degli
ultimi anni e il ciclo Venec mertvym (Un serto ai
morti), in memoria degli amici scomparsi, vittime delle persecuzioni
e delle stragi staliniane.
Ormai riconosciuta anche in patria, e dalle stesse istituzioni
culturali sovietiche, come uno dei massimi poeti russi del
secolo, muore il 5 marzo 1966 a Domodedovo, presso Mosca, per
un attacco cardiaco.

Dall’indice: Amedeo
Modigliani; Mandel’ štam (Fogli d’album); Ricordo
di Aleksandr Blok; Sui versi di Nadežda
L’vova; «Slovo» su Puškin; L’«Adolphe» di
Benjamin Constant nell’opera di Puškin; «Il
convitato di pietra» di Puškin; Postfazione di
Eridano Bazzarelli; Nota biografica; Appendice iconografica
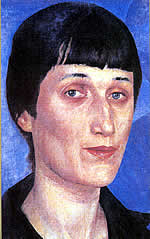
Collegamenti
 http://annaachmatova.altervista.org/ http://annaachmatova.altervista.org/
 http://www.larici.it/ http://www.larici.it/
|

