Martin
Parr, Gerry Badger
The Photobook: A History volume I
London, Phaidon Press, 2004
Il
volume è presente nel catalogo della Biblioteca Nazionale di
Napoli (segnatura: Lucchesi Palli Arte V 120)
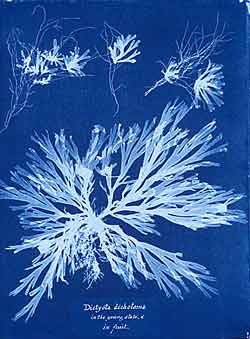 Qual è il
destino della fotografia? Percepita distrattamente, sfogliando
un giornale, passeggiando davanti a un manifesto pubblicitario,
o al contrario, osservata con estatica attenzione in una galleria
d’arte, l’immagine fotografica è destinata,
per sua natura, a mille usi e consumi. Del resto, sin dal suo
apparire la fotografia scompigliò le carte in tavola,
ostentando la strutturale ambiguità dei suoi statuti semiotici
ed estetici. In molti - storici dell’arte, filosofi, studiosi
dei mezzi di comunicazione - hanno indagato, da subito, sulla
natura di questa ambiguità: alla fine di una secolare
evoluzione tecnologica, iniziata con le tavole xilografiche,
si è offerta come lo strumento definitivo per la riproduzione
seriale delle immagini; al contempo,
ha insidiato la pittura sul campo prima della imitazione della
natura, e poi, anche, della produzione artistica tout court,
dentro i flussi linguistici contaminati della comunicazione contemporanea.
Di certo la fotografia, molto più della pittura ormai,
ha molti destini, anche se su tutti sembra comunque prevalere
quello del suo consumo spicciolo, quotidiano, a volte compulsivo
e ottuso, funzionale a quella che Ando Gilardi - in una delle
sue tante straordinarie storie dell’immagine - ha definito «la
società dello spreco iconico».
Qual è il
destino della fotografia? Percepita distrattamente, sfogliando
un giornale, passeggiando davanti a un manifesto pubblicitario,
o al contrario, osservata con estatica attenzione in una galleria
d’arte, l’immagine fotografica è destinata,
per sua natura, a mille usi e consumi. Del resto, sin dal suo
apparire la fotografia scompigliò le carte in tavola,
ostentando la strutturale ambiguità dei suoi statuti semiotici
ed estetici. In molti - storici dell’arte, filosofi, studiosi
dei mezzi di comunicazione - hanno indagato, da subito, sulla
natura di questa ambiguità: alla fine di una secolare
evoluzione tecnologica, iniziata con le tavole xilografiche,
si è offerta come lo strumento definitivo per la riproduzione
seriale delle immagini; al contempo,
ha insidiato la pittura sul campo prima della imitazione della
natura, e poi, anche, della produzione artistica tout court,
dentro i flussi linguistici contaminati della comunicazione contemporanea.
Di certo la fotografia, molto più della pittura ormai,
ha molti destini, anche se su tutti sembra comunque prevalere
quello del suo consumo spicciolo, quotidiano, a volte compulsivo
e ottuso, funzionale a quella che Ando Gilardi - in una delle
sue tante straordinarie storie dell’immagine - ha definito «la
società dello spreco iconico».

Scrivere
la storia della fotografia vuol dire perciò scrivere tante
storie insieme: tecnica, sociale, artistica, e molte altre ancora.
Una di queste, non consueta per il punto di vista prescelto,
si deve a Martin Parr e Gerry Badger, autori di un bel libro, The
Photobook: A History,
edito nel 2004 dalla londinese Phaidon. Il loro intento dichiarato è stato
quello di delineare una storia della fotografia così come
si manifesta attraverso l’evoluzione del libro fotografico.
Cos’è un libro fotografico? Secondo
il critico olandese Ralph Prins - citato nell’introduzione
- «A photobook is an autonomous art form, comparable
with a piece of sculpture, a play or a film. The photographs
lose their own photographic character as things ‘in themselves’ and
become parts, translated into printing ink, of a dramatic event
called a book». Non bastano perciò delle
belle fotografie - è l’opinione di Parr e Badger
- per fare un buon fotolibro, così come un ottimo fotolibro
può contenere fotografie non straordinarie. Un libro fotografico è,
insomma, qualcosa di più e di diverso di un contenitore
di immagini: è una «forma di arte autonoma»,
che si esprime non solo negli specifici linguaggi
della fotografia, ma attraverso il progetto grafico complessivo,
la scelta dei caratteri e dell’impaginazione, il rapporto
tra testo e immagine, le modalità della scansione narrativa.
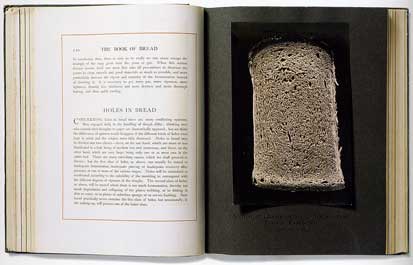

I
manuali di storia della fotografia definiscono come primo libro
fotografico The pencil of nature di quel William Henry
Fox Talbot a cui si deve l’affermazione del principio
negativo-positivo su cui si basa la fotografia. Il procedimento
di Talbot, chiamato calotipia (o
anche talbotipia),
al contrario della dagherrotipia, permetteva di stampare
più copie da un’unica matrice su carta, e subito
Talbot impiegò la tecnica per pubblicare il suo libro,
in 6 fascicoli usciti tra il 1844 e il 1846. Conteneva
24 calotipi originali che rappresentano un vero e proprio manifesto
della nuova arte e delle sue possibilità di riproduzione
della realtà, con rappresentazioni di paesaggi naturali,
di architetture, di oggetti archeologici e artistici. Ma non è -
e per molti questo costituirà una sorpresa - la celebre
opera di Talbot ad aprire la selezione, bensì le immagini
raccolte nell’album Photographs of British Algas:
Cyanotype impressions, che precede di qualche mese l'opera
di Talbot. L’autrice è una
studiosa di botanica inglese, Anna Atkins, che utilizzò la
cianotipia - tecnica ideata da quello che può definirsi
il vero inventore della fotografia, Sir John Herschel - per
realizzare quasi quattrocento stampe a contatto, senza cioè l’uso
di lenti o apparecchiatura ma poggiando i suoi soggetti direttamente
sulla carta sensibile. Il risultato è straordinario,
ben oltre gli scopi scientifici che la Atkins si proponeva:
il ferrocianuro di potassio impone a quell’erbario il
tipico colore blu delle cianotipie, disegnando sulla carta
delicate e affascinanti silhouettes.
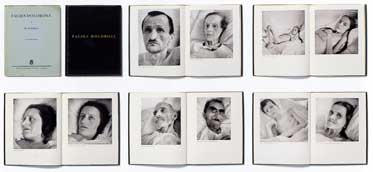
Questo
volume - che si ferma agli anni ‘70 - organizza i materiali
seguendo una convincente scansione tematica: i primi fotolibri,
dedicati soprattutto alle riprese naturalistiche e geografiche;
lo sviluppo delle possibilità di
riproduzione della realtà ai fini degli studi scientifici,
antropologici, documentaristici; l’affermarsi della fotografia
come arte e delle estetiche pittorialiste prima e poi delle avanguardie;
i reportages sociali degli anni '30;
il fotolibro come strumento della propaganda di regime; la fotografia
europea al servizio della memoria e testimonianza della ricostruzione
dopo la seconda guerra mondiale; i nuovi linguaggi fotografici
degli anni ’60-’70; il fotolibro giapponese post-bellico.

È impossibile
dar conto della mole dei titoli selezionati e descritti dagli
autori, e oltre che sui tantissimi grandi nomi e delle celebri
immagini che incontriamo scorrendo il ponderoso volume - da Eadweard
Muybridge a Jacob Riis, da Julia Margaret Cameron a Walker Evans,
da Berenice Abbott a Dorothea Lange, da André Kertész
ad Henri Cartier-Bresson, da Paul Strand a William Klein, da
Joseph Koudelka a Diane Arbus, ma la lista è lunga
- il lettore non può non soffermarsi su tante interessanti
scoperte e curiosità che riserva questo libro. Come ad
esempio quel Book of Bread di Ower Simmons pubblicato
a Londra nel 1903 le cui immagini esplorano con lo stesso rigore
e precisione con la quale si studia un pianeta sconosciuto un
banale oggetto della vita quotidiana (il pane, appunto). Oppure,
all’opposto per la sua carica disturbante, Facies Dolorosa:
Das Schmerzensreiche Antiltz (1934) del Dr. H. (Hans) Killian,
il “volto del dolore” raffigurato in una serie di
primi piani di malati terminali, costruiti con sapienza compositiva
e tecnica raffinata, un ulteriore contributo a quell’estetica
della sofferenza in bilico tra compassione e compiacimento che
tanta parte ha avuto nella storia dell’immagine fotografica.
Anche il capitolo dedicato al libro di propaganda è fonte
di qualche sorpresa: per celebrare i regimi totalitari, soprattutto
nel caso dell’URSS, si utilizzano i linguaggi delle avanguardie
artistiche, si ricorre a complesse soluzioni grafiche, ad ardite
impaginazioni, in cui l’immagine fotografica è parte
integrante di un progetto comunicativo di notevole impatto. Infine
sono da segnalare almeno, tra i Provocative Materials
for Thought - come si intitola l’ultimo capitolo dedicata
al Giappone - le opere nate dalla collaborazione tra Heikoh Hosoe
e Yukio Mishima. Nel ciclo Barakei l’immaginario
dello scrittore è messo in scena e trasfigurato attraverso
uno delle più complesse imprese foto-grafiche mai realizzate
nella storia dell’editoria.
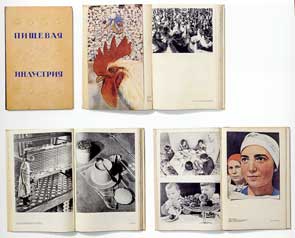

Scarna
la presenza nel volume di titoli italiani. Insieme al canonico Fotodinamismo
futurista (1913) di Bragaglia viene segnalato ad esempio, La
colonizzazione del latifondo siciliano, una pubblicazione
del 1940 del Ministero dell’Agricoltura e delle foreste
che documenta i lavori di risanamento delle aree depresse della
Sicilia, inserita nella sezione dedicata alla propaganda di regime.
Nello stesso capitolo è citato un altro piccolo monumento
iconografico al fascismo, quel massiccio numero della Rivista
illustrata del Popolo d’Italia interamente dedicato
all’esaltazione dell’Italia imperiale, come
recita il titolo della monografia. Tra gli altri volumi segnalati, Milano,
Italia (1959) di Mario Carrieri, ancora Milano (1965)
di Giulia Pirelli e Carlo Orsi, il reportage sui Travestiti (1972)
di Lisetta Carmi, Kodachrome (1978) di Luigi Ghirri. Scelte
tutto sommato non banali, che mettono in secondo piano qualche
dimenticanza, come - per citare le più evidenti - quelle
di Berengo Gardin o dello Strand che collabora con Zavattini
per il mitico libro su Luzzara edito da
Scheiwiller nel 1955. Ma sarebbe ingeneroso
fare le pulci ad un’opera così ricca e completa
(e aspettiamo comunque impazienti di leggere la seconda parte).
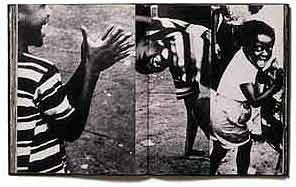
Ha
ancora un futuro, nella civiltà dell’immagine elettronica,
il libro fotografico? Forse il secondo volume di questa storia
di Parr e Badger - che, ovviamente, è un libro che parla di fotolibri
diventando a sua volta un fotolibro - ci offrirà delle
indicazioni e spunti di riflessioni. Sappiamo comunque che c’è ancora,
vivaddio!, chi si diverte in progetti estremi ed eccessivi. Ce
lo dimostra ad esempio Sumo, un tributo a un grande fotografo
dei nostri tempi, Helmut Newton, edito da Taschen nel 1999. Il
volume, progettato nel suo impianto tipografico da Philippe Starck,
misura 50x70 cm per un peso di ca. 30 chili. Nella sue 464 pagine
le inconfondibili immagini del fotografo recentemente scomparso,
stampate con perfezione assoluta, risaltano in tutto il loro
freddo splendore. Il problema è solo
trovargli un posto nella libreria di casa, e prima ancora di
racimolare i 5000 euro necessari per comprarselo!



